Mario Ciancio, Catania e gli intellettuali di corte
«Io ho un insegnamento: al processo Tortora a Napoli c’erano tre catanesi, killer delle carceri, Andraus, Nino Faro e Marano. Andai a parlare con loro, dietro le sbarre. Loro erano accusati di associazione camorristica e mi dissero: “Ma quale camorra, ma quale mafia, noi catanesi siamo”. Cioè, da allora mi è rimasta questa etichetta qua, secondo cui Catania soffre di un’enorme, pericolosissima criminalità, ma che chiamarla Cosa nostra mi pare un po’ fuori posto». Queste parole di Tony Zermo, inviato del quotidiano La Sicilia, pronunciate al processo per l’omicidio di un altro giornalista, Giuseppe Fava, fondatore del mensile I Siciliani, condensano la linea del giornale diretto da Mario Ciancio, sull’esistenza della mafia a Catania. Una linea che il quotidiano applicava ancora prima dell’«insegnamento» impartito dai tre killer a Zermo, tanto che nell’ottobre dell’82, quando tutta la stampa nazionale riportò la notizia del mandato di cattura dei giudici palermitani nei confronti di Nitto Santapaola (poi assolto) per l’omicidio del generale dalla Chiesa, La Sicilia tacque il fatto ai propri lettori: li informò il giorno dopo, minimizzando lo spessore criminale del capo di Cosa nostra etnea.
Un’allergia, quella verso il termine mafia, che La Sicilia fa valere anche per i necrologi, tanto che nell’ottobre del 1985 la famiglia Montana di vede rifiutare quello che ricorda il loro congiunto, Beppe, il commissario di polizia ucciso a Palermo tre mesi prima.
Una linea “antimafia” che lo stesso Ciancio, nei primi anni Novanta, fa valere con un cronista che aveva osato definire «mafiosa» la famiglia Ercolano: il capoclan si presenta da Ciancio – ricostruisce il Gip Ferrara, nell’istruttoria del processo Fava –, che lo riceve e, in sua presenza, convoca il cronista e gli intima di «non definire più mafiosi gli Ercolano, nemmeno se la fonte è giudiziaria». Gli Ercolano, imparentati con Santapaola, sono noti boss catanesi e uno dei rampolli, Aldo, è stato condannato, con Santapaola, per l’omicidio di Giuseppe Fava, ucciso il 5 gennaio 1984.
Proprio sul caso Fava, La Sicilia dà il “meglio” di sé in numerose occasioni. Subito dopo il delitto sostiene che sia «un colpo sferrato da chi ha interesse a distruggere gli equilibri catanesi» (Zermo). Insomma: un complotto contro la città. Scartata l’ipotesi che Fava sia stato ammazzato per il suo lavoro di giornalista e per le inchieste sui Siciliani perché «ha fatto i nomi che facevano tutti» (sempre Zermo) e perché era «un poeta, un sognatore, un Don Chisciotte» (ma si insinua pure che fosse «un Pecorelli catanese», cioè un personaggio ambiguo). Invece, fin dal primo numero, un anno prima, il giornale di Fava aveva rotto il silenzio sull’intreccio mafia-politica-imprenditoria-giustizia a Catania indicando i quattro maggiori imprenditori cittadini (Mario Rendo, Gaetano Graci, Carmelo Costanzo e Francesco Finocchiaro, sui quali già indagava dalla Chiesa) come collusi con i clan, coniando l’espressione «i quattro cavalieri dell’apocalisse mafiosa». Nomi che sul giornale di Ciancio comparivano solo come fulgido esempio di «imprenditoria di livello europeo» e che non leggerà accostati a mafia e a malaffare finché non saranno travolti dalle inchieste giudiziarie degli anni successivi.
Nell’estate del 1984 il quotidiano di Ciancio fa uno “scoop” senza eguali nella storia del giornalismo: annuncia che «Un detenuto “pentito” della malavita catanese svelerà i nomi degli uccisori di Giuseppe Fava». Mai successo che la collaborazione di un malavitoso sia anticipata prima che i magistrati lo interroghino. Nell’articolo, corredato di foto dell’uomo, sono indicati il carcere in cui è recluso e il suo indirizzo di casa, dove vivono i familiari. Quando arriva il pm, il “pentito” gli mostra l’articolo e fa scena muta.
Dieci anni dopo, nel giugno del 1994, si “pente” Maurizio Avola, killer del clan Santapaola, indica mandanti ed esecutori dell’assassinio del direttore dei Siciliani (Nitto Santapaola, Aldo Ercolano e altri) e accusa l’imprenditore Gaetano Graci (morto durante le indagini). La Sicilia scrive che Avola si è autoaccusato di essere «il killer di dalla Chiesa e di Fava», ma all’epoca del primo delitto «aveva appena ventuno anni» e, dunque, non è credibile. L’articolo è firmato da un collaboratore messinese, Salvatore Pernice. Sul Giorno, lo stesso articolo, con le stesse parole e identici refusi, è firmato da Zermo. Due pm della Dda etnea, Mario Amato e Amedeo Bertone, smentiscono che il nuovo collaboratore abbia parlato del generale e denunciano «un’operazione studiata a tavolino per screditarlo». Ma il giorno dopo La Sicilia e il Giorno (ancora Zermo), ribadiscono che Avola «ha confessato» entrambi i delitti. A quel punto la Procura convoca una conferenza stampa e chiarisce definitivamente che Avola non c’entra con l’omicidio dalla Chiesa; ma secondo un occasionale cronista di Ciancio, i magistrati avrebbero «smentito categoricamente le clamorose “falsità” attribuite al pentito sui delitti dalla Chiesa e Fava».
Non è tutto. Salvatore La Rocca, cronista di giudiziaria del quotidiano etneo, durante un’udienza del processo, nel 1996, si offre a uno dei legali dei killer per suggerirgli «le domande che deve fare a Claudio Fava», figlio della vittima e parte civile, che in quel momento era sul banco dei testimoni. La Rocca è stato censurato dall’Ordine dei giornalisti.
Gennaio 2002, diciott’anni dopo l’omicidio. La facoltà di Lingue dell’università di Catania organizza un convegno di studi su Giuseppe Fava. La Sicilia, pochi giorni prima dell’iniziativa, rimpiange «la grande imprenditoria dei cavalieri del lavoro spazzati dall’ondata giustizialista seguita al delitto Dalla Chiesa». Il pezzo è firmato da Tony Zermo. Nel 1998, sempre Zermo, aveva scelto il giorno successivo all’anniversario del delitto per recriminare sulla scomparsa dei cavalieri, così bravi e potenti «da attirare non solo ammirazione, ma anche invidia, tanto che qualcuno, negli anni bui li soprannominò i “quattro cavalieri dell’apocalisse mafiosa” come se i mali della città dipendessero da loro». Giuseppe Fava derubricato a «qualcuno» e «invidioso».
Il 9 ottobre del 2008 il “pezzo” d’apertura della cronaca cittadina è vergato da un cronista d’eccezione, Vincenzo Santapaola, figlio di don Nitto e, come il più illustre genitore, ristretto al 41 bis in un carcere del nord Italia. Non è un vero e proprio artcolo, anche se è impaginato come tale, è una lettera di autodifesa del rampollo del capo di Cosa Nostra catanese, novello Silvio Pellico, non accompagnata da alcun commento redazionale. Un fulgido esempio di grande giornalismo che aveva un precedente identico, risalente a una ventina d’anni prima, a quando il presunto killer mafioso Antonino Cortese, all’epoca indiziato (poi prosciolto) del delitto Fava, ebbe il privilegio di inaugurare questo nuovo filone di “giornalismo carcerario”, con una lettera di autodifesa pubblicata come articolo di apertura della cronaca. Senza alcun commento, naturalmente.
E il direttore-editore Mario Ciancio, che ne pensa di tutto ciò? Al processo per l’omicidio Fava, dov’è stato chiamato a testimoniare dalle parti civili, ha dichiarato: «Non esercito alcun controllo sugli articoli. Sono il padrone del giornale, mi preoccupo di mille cose, non dei particolari». Già, ai «particolari» ci pensano alcuni suoi “giornalisti”.




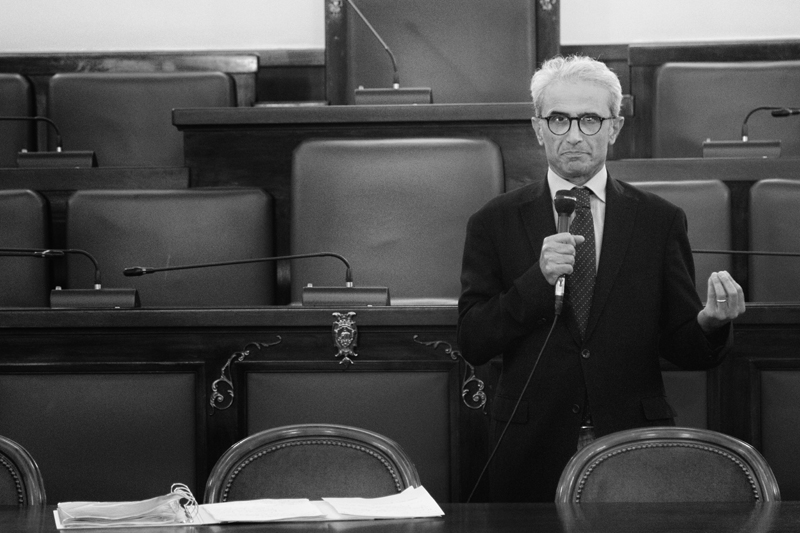
passaparola………
Caro Direttore Riccardo Orioles,
Cara Redazione di I Siciliani giovani,
Il Direttore del quotidiano più diffuso della Sicilia orientale e centrale, Dottor. Mario Ciancio Sanfilippo, denominato ” La Sicilia”, viene indagato dalla Procura della Repubblica di Catania per riciclaggio e concorso esterno in associazione mafiosa.
Dapprima le prove formulate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della città catanese vengono archiviate – evidentemente per insufficienza di prove -, ma il Gip del Tribunale le respinge motivando una nuova indagine, al fine di approfondire meglio l’istruttoria.
La Procura della Repubblica di Catania delega per le successive indagini il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Comandante Alessandro Casarsa, che approfittando della nuova nomina si fà intervistare presso la sede del quotidiano in riferimento.
Mi si permetta immediatamente un paragone, che sicuramente ricorderete.
A Palermo il Colonnello Comandante, Carlo Alberto Dalla Chiesa, della Legione Carabinieri mai si sarebbe fatto intervistare in ” casa” di un indagato.
Profetica è la seguente frase da Prefetto della Repubblica di Palermo, Generale di Corpo d’Armata, Carlo Alberto Dalla Chiesa: ” Un amico con cui hai avuto un rapporto di affari, di ufficio, ti dice, come per combinazione: “perché non andiamo a prendere il caffè dai tali”. Il nome è illustre. Se io non so che in quella casa l’eroina scorre a fiumi, ci vado e servo da copertura. Ma se io ci vado sapendo, è il segno che potrei avallare con la sola presenza quanto accade”.
Quindi, secondo la frase del Generale Dalla Chiesa, l’indagine investigativa delegata dalla DDA catanese al Colonnello Casarsa potrebbe – sicuramente!? – subire la mancanza di riserbo e la sicurezza che meriterebbe. Fors’anche con il rischio di comunicare all’indagato sviluppi dell’indagine che lo riguardano, facendo intervenire la Procura della Repubblica di Catania che indagherebbe l’indagatore per ” mancanza di riservatezza in indagini coperte dal segreto d’ufficio”.
Rendendo vano l’approfondimento dell’indagine, e mettendo a repentaglio la vita di chi è stato delegato dal Colonnello Casarsa ad indagare:esempio a futura Memoria: il Maresciallo Maggiore Giuliano Guazzelli,soprannominato” Il mastino” e Maresciallo Maggiore Vito Jevolella, che erano contesi – guarda caso – dal Generale Dalla Chiesa.
Grazie!…