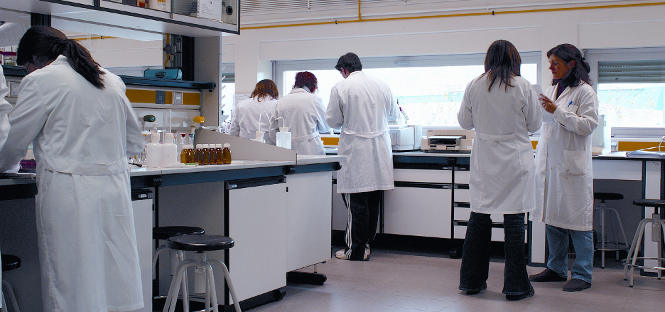Il ricercatore universitario, un passo avanti (e due indietro)
La figura del ricercatore universitario sta lentamente sparendo. Con lei sparirà anche la ricerca accademica, che rimarrà ad appannaggio di pochi gruppi di ricerca, sempre meno numerosi, sicuramente più ricchi. Chi ha avviato questo lento piano inclinato verso il declino? Cosa (non) si sta facendo per arrestare questa tendenza? La catena del disastro raccontata dall’interno.
La legge 240/2010, nota come legge Gelmini, ha riformato il sistema universitario abolendo la figura del ricercatore universitario a tempo indeterminato (RUTI) a favore della figura dell’RTD (ricercatore a tempo determinato). Il RUTI è stato per anni una figura essenziale per la ricerca accademica. E la ricerca si fa in un gruppo, al cui vertice c’è il “Principle Investigator” (PI), generalmente un professore di I (quasi sempre) o II fascia (quasi mai). Il PI è quello che sostiene la ricerca con i finanziamenti ottenuti, a lui sono affidati gli spazi di pertinenza del Dipartimento per ubicare il proprio laboratorio. Poi occorre qualcuno che gli esperimenti li faccia e che non abbia il carico didattico che giustamente ha un professore di I o II fascia. E questa figura prima del 2010 era il RUTI, che nell’attività di laboratorio era affiancato da figure in avanzamento di carriera, quali i dottorandi e gli assegnisti di ricerca (i famosi “post-doc”). Che poi al RUTI venissero affidati incarichi didattici dai propri PI era normale prassi.
Una prassi, però, che inevitabilmente ha portato all’implosione del sistema quando molti corsi di laurea si reggevano sulla figura del RUTI ormai diventati in numero maggiore rispetto ai professori di I e II fascia. Questo perché una posizione da RUTI allo stato costava meno rispetto a quella di professore di II fascia. Quanto alla possibilità di poi rifiutare legittimamente la docenza non dovuta avrebbe significato l’impossibilità di avanzare nella propria carriera per dinamiche accademiche che conosciamo bene e che potremmo riassumere nella parola “barone”.
E così i nodi arrivarono al pettine e si arrivò alla necessità di riformare il sistema universitario. I RUTI non vanno più in aula, mancano i docenti quindi, e allora che si fa? Si abolisce la figura del RUTI e si introducono i “nuovi ricercatori” a tempo (RTD), con l’obbligo di un carico didattico che li sposta dal bancone alla cattedra per tre anni.
E la ricerca chi la fa? Si guarda in basso, e la si affida sempre più in mano agli assegnisti di ricerca: la figura più emblematica del precariato universitario. Che figura è? È un dottore di ricerca con un salario di circa 1300 euro al mese per 12 mensilità, spesso da fuorisede in città care come Milano e Roma; trattamento previdenziale con gestione separata INPS in cui il contributo è in parte trattenuto all’assegnista (1/3 dell’importo lordo dell’assegno). Assegno che può essere ricevuto per un massimo di 6 anni senza alcun riconoscimento dei rischi (biologico, chimico, fisico) che si corrono nella pratica di laboratorio. Prima della riforma Gelmini, l’assegnista era “in coda” per una figura di RUTI. L’unico determinante era il volere del suo PI.
Con la riforma Gelmini l’assegnista si mette “in coda” per una figura da RTD. Qui il determinante oltre al volere del PI era il raggiungimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN). Se non hai l’ASN per il tuo settore non puoi diventare professore di II fascia. Ma peggio, se non hai l’ASN gli atenei spesso nemmeno attivavano le procedure concorsuali per un RTD di tipo B (RTD-B), quello con il meccanismo del tenure track, cioè che dopo il triennio da RTD, se hai l’ASN, si diventava automaticamente professore di II fascia.
È una “policy” estremamente scorretta che gli atenei adottavano (e adottano ancora, vedremo in seguito) per non vanificare una posizione permanente, togliendo agli RTD-B tre anni di tempo per raggiungerla e obbligandoli a farlo nel periodo da post-doc. Periodo composto al massimo da 6 anni di assegno di ricerca a cui si potevano aggiungere tre anni di RTD-A, ricercatore a tempo senza la formula del tenure track. Come si ottiene l’ASN? Si deve passare per il raggiungimento di alcuni parametri bibliometrici (che in generale tengono conto della produzione e dell’impatto della ricerca), più parametri non matematici in cui la commissione ha il margine per “scegliere” i candidati utilizzando parametri quali l’attività di docenza. Quindi anche l’assegnista se vuole avere chance di ottenere l’ASN è costretto (gratuitamente) a prendere del carico didattico.
E siamo al punto di partenza. Serve una nuova riforma. E qui ci pensa Draghi. L’articolo 14 comma 6 septies del Decreto PNRR 2 convertito in Legge in vigore dal 29 giugno 2022 ha introdotto il contratto di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca, attivabili fino al 31 dicembre 2023. Con la riforma vengono inoltre eliminate le figure RTD-A e RTD-B, introducendo l’unica figura dell’RTT (ricercatore tenure track).
Il contratto di ricerca è una forma più evoluta di precariato universitario in cui lo stipendio non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, circa 1800 euro mensili. Durata? Biennale, rinnovabile per un altro biennio e comunque per un massimo di cinque anni. Fine delle buone notizie. Ora vediamo i problemi. Come detto in precedenza nell’era Gelmini dopo il dottorato di ricerca si entrava nel periodo del post-doc con circa sei anni di assegni di ricerca a cui si poteva affiancare un triennio da RTD-A. A conti fatti si aveva un periodo di tempo (ovviamente da precario) dai 6 ai 9 anni per raggiungere l’ASN prima della tenure track. Se dopo questo periodo si mancava l’obiettivo dell’ASN (che ha i suoi tempi e che spesso non dipendono solo dalle volontà del post-doc) si era fuori dall’università. Dati alla mano solo il 6% dei post-doc riusciva ad arrivare alla tenure track, una percentuale drammatica.
Con la nuova riforma il tempo da post-doc si è ridotto ad un massimo di cinque anni, e se da un lato ciò riduce il periodo di precariato, dall’altro si avrà ancora meno tempo per raggiungere i parametri bibliometrici per l’ottenimento dell’ASN. E a quel punto si sarebbe fuori dall’università ancor prima di quanto accade con il sistema degli assegni (ecco la beffa). La percentuale di completamento della carriera scenderebbe oltre il 6%. Inoltre, il MUR, già indietro con la definizione giuridica del contratto collettivo di ricerca, non ha ancora previsto finanziamenti con dei budget idonei a sostenere le spese di attivazione dei nuovi contratti (giustamente più onerosi); budget attuali idonei per attivare al massimo degli assegni di ricerca.
E quindi? Nuova riforma? Macché, il ministero si mette al passo della ricerca italiana: uno avanti, due indietro. Si rimane con gli assegni di ricerca anche per il 2024. Una prece.